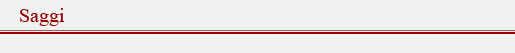
IL RECUPERO DI UNA COMUNITA’ SMEMBRATA
Maricla Boggio
Intorno alla metà degli anni Sessanta ero allieva di Orazio Costa per il triennio di regia all’Accademia “Silvio D’Amico”. Le lezioni di noi registi prendevano parecchio tempo perché si estendevano, al di là degli impegni insieme agli allievi di recitazione, ad altri incontri con il Maestro dedicati all’interpretazione dei testi e al lavoro con gli attori nostri compagni.
La mia curiosità di teatro sconfinava dai canoni dell’Accademia d’Arte Drammatica spingendomi anche in territori dai puristi considerati pericolosi e infidi. In quegli anni si cominciava a parlare di Grotowski, il maestro polacco chiuso in una sperimentazione con gli attori da cui pareva ottenere prodigi di una espressività innovativa rispetto ai criteri del teatro dell’epoca. Spiato nei pochi articoli che riuscivo a trovare su di lui, Grotowski si materializzò per me nel 1965 in un Convegno a Roma; lo organizzava Alessandro Fersen, di cui avevo sentito parlare, ma che non conoscevo. Di lui chiesi a Costa, che non mi disse molto, ma usò un tono di rispetto per la sua attività di docente: teneva una scuola che, al di là di un insegnamento tradizionale da lui adottato per gli allievi, si caratterizzava come luogo di ricerca attraverso un metodo messo in atto in particolari momenti del suo insegnamento. Andai agli incontri che si tennero nello Studio di Fersen, in un vasto spazio alla Lungara, intorno alla figura di Grotowski, a cui parteciparono alcuni fra i più significativi esponenti del teatro di quegli anni, critici, autori, attori, studiosi e docenti, direttori di teatro, Giorgio Prosperi, Ghigo de Chiara, Renzo Tian, Mario Raimondo, Elio Pagliarani. Io ero fra i giovani che ascoltavano, cercando di collegare quanto andava sviluppandosi attraverso gli interventi con ciò che conoscevamo del teatro. Grotowski mi parve una sorta di santone vestito da impiegato di banca, proteso a superare i limiti umani dell’espressività con la pazienza tenace circa il tempo degli esercizi, “la fede”, disse in un suo intervento Ferruccio Marotti, giovanissimo e già ad altezze universitarie.
Era invece una serena laicità a condurre la ricerca di Fersen sull’attore. Ma era anche immerso nel teatro attivo, su cui tentava di intervenire cercando di plasmarlo per quanto possibile secondo propri parametri. Era un ricercatore puro che tuttavia, a rischio di contraddizione, non aveva rinunciato a operare nel teatro del suo tempo, in cui doveva accettare di realizzare spettacoli secondo i mezzi e gli attori che poteva reperire, oppure ritirarsi in un dignitoso quanto improduttivo apartheid.
Attraverso confronti e ipotesi di tendenza formativa del suo ininterrotto lavoro, emerge in primo luogo la volontà di realizzare un attore lontano dai clichés, per iniziare una trasformazione del teatro del suo tempo mediante un progetto che lo riscatti dalle incrostazioni delle mode e dai pettegolezzi divistici facendolo ritornare elemento vitale di aggregazione e di rappresentazione della comunità.
Rimando a quanto scrive lo stesso Fersen circa il mnemodramma. Il lavoro che ne risulta è una sorta di scavo nelle profondità dell’individuo più segreto che, in un particolare momento favorevole per il suo stato d’animo e le presenze da cui è circondato e per il luogo in cui si trova, guidato dal maestro si abbandona a far riaffiorare da sé elementi, sensazioni, ricordi ignorati o dimenticati. Questa pratica, definita con il termine “reviviscenza”, può forse essere presentificata in modo più pregnante come ricordo di elementi che appartengono alla personalità più oscura dell’individuo, nel loro affacciarsi fuori di lui, trovandovi una forma di espressione.
Abbandono e controllo ne sono gli elementi determinanti, come con precisione di linguaggio Fersen spiega in alcuni suoi saggi. Essenziale in tale approccio dell’attore con se stesso è una totale volontà di affondare in profondità nella propria psiche, abbandonando il livello razionale e ricercando nell’inconscio la propria natura originaria.
Si può forse pensare che Fersen abbia avvertito l’influenza di Gurdieff, filosofo dell’esoterismo, in questo ampliamento della coscienza e nel crepuscolo di essa.
In tale abbandono ci si libera dalle stratificazioni indotte dal comportamento sociale della propria epoca, dalle costrizioni e dagli infingimenti dettati da un’educazione costrittiva e schematica. Si tratta di una sorta di pulizia della propria espressività, che torna a ritrovare una libertà primigenia.
Da questa liberazione l’individuo può partire per iniziare un percorso per l’interpretazione teatrale.
Il procedimento - mette in guardia Fersen - comporta pericoli di sbandamento psichico se non viene guidato con delicatezza e consapevolezza da un maestro. Era lo stesso Fersen a seguire questi esperimenti, che appartenevano ad un settore laboratoriale particolare della sua Scuola rispetto al resto delle esercitazioni da cui scaturivano gli attori, ma i due tipi di impegno non necessariamente erano divisi, potendo gli allievi passare da un settore all’altro.
Ricordo qualche incontro a cui assistetti nel suo studio, accanto al Maestro. Ciò che dagli allievi affiorava soprattutto era una sorta di angoscia, di tormento interiore che cercava di farsi strada dentro di loro: sentimenti ed emozioni emergenti dal profondo. Era lo stesso Fersen a spingere gli allievi a questi lidi, in un modo o nell’altro sotterraneamente presenti in ciascuno di noi, purché - lui diceva - “si sollevasse un po’ di sabbia dalla superficie”.
Di questi rari momenti di lavoro relativo al mnemodramma, Fersen era giustamente geloso come di momento privatissimo, in collegamento fra lui e chi vi si sottoponeva. Mi riferisco in particolare al mnemodramma singolo, senza oggetti, quello che più induce l’attore a scavare dentro di sé individuandovi elementi da lui stesso ignorati.
Non so per quale motivo, se non quello di una rara simpatia e fiducia nei miei confronti, - ero conosciuta come “l’allieva di Costa” - o per una sorta di sfida a mostrarsi a chi seguiva altre modalità di sollecitazione creativa, abbiano indotto un giorno Fersen a farmi partecipare, come spettatrice, a questo suo segreto ed intimo lavoro.
Ricordo il volto del giovane che si era offerto - o lo aveva scelto il Maestro?, questo non lo ricordo -, forse si trattò di una sintonia o di un invito da parte di Fersen verso chi sapeva avrebbe risposto alle sue attese, pur libere rispetto al risultato, ma certo comunque di ottenere un risultato stimolante.
Intorno, il buio di un luogo dentro il quale altri individui assistono ignorati e silenziosi, come dietro lo specchio dello psicanalista. Come chiamare quanto sta accadendo? Lavoro, esercizio, scavo, sollecitazione, rito... Forse l’ultima definizione si attaglia alla procedura ed al silenzio in cui si svolge l’operazione. Il giovane si concentra sul riflettore che gli sta davanti, occhio indagatore per lui, semplice fonte luminosa, finora, per me. Ne sembra abbagliato e al tempo stesso trascinato in un altrove che lo distanzia da noi, non tanto però da non avvertire da parte sua la presenza di Fersen, che lo segue non perdendolo d’occhio, pur in silenzio - ma questo genere di attenzione di solito viene avvertita da chi vi è abituato -, e quindi il giovane non ne è distolto, pare anzi sentirsene sostenuto: è una mia impressione, ma credo che essa sia adeguata alla situazione che si viene creando.
Il ragazzo si concentra su qualcosa che sente dentro di sé; gli occhi paiono scrutare la sua interiorità perché hanno abbandonato la fonte di luce in faccia a lui, ma pur restando spalancati paiono vedere al di là di quanto è davanti. Il respiro del ragazzo si fa leggero, come sospeso, rarefatto; pare ascoltare suoni - o parole? - che soltanto lui è in grado di percepire, a causa di una attenzione profonda, che supera la concretezza del momento contingente e del luogo reale.
Il ragazzo pare via via apprendere cose particolarmente importanti per lui, si direbbe - a mio avviso - che stia venendo messo a parte di una qualche rivelazione, che lui stesso si scopre dentro, da sempre appartenutagli, ma ignorata. Non riesco a capire se ne sia turbato; forse ne è stupito, a giudicare dall’espressione del volto via via sempre più proteso verso un altrove attrattivo.
Passano così alcuni secondi, forse qualche minuto, ma il tempo si dilata e insieme non sembra trascorrere, tanta è la tensione-attrazione che è venuta a crearsi. Poi la rivelazione deve essere avvenuta, perché il ragazzo fa dei piccoli cenni con il capo, ad affermare ciò che va apprendendo, e ad un tratto pare indietreggiare davanti ad un compito - forse - che gli viene indicato, o che lui stesso dentro di sé sente di dover affrontare; ha un piccolo moto reticente, una sorta di scatto all’indietro e per la prima volta sbatte gli occhi che aveva tenuto spalancati e fissi; il respiro gli si fa più contratto, direi quasi un accenno di affanno, che va crescendo: è forse un affacciarsi di quella che Fersen chiama “angoscia”, e che si verifica in chi è dentro all’esercizio come una scoperta di ancestrali memorie, non quindi ricordi, ma scoperte di qualcosa di “altro da sé”.
E’ qui che Fersen richiama dolcemente il ragazzo, sottraendolo a quella sorta di ipnosi, ma con un tono di voce suadente e sereno, che impone senza trauma all’allievo di riemergere da una sorta di situazione di discesa “ad infera” da lui sostenuta. Ecco allora che con un piccolo scatto quasi a saltare fuori da un recinto, il ragazzo sbatte ancora gli occhi, si scrolla tutto e poi si guarda intorno, fermando lo sguardo al Maestro, fino a sorridergli. “Bene - dice Fersen con garbo -. Come ti senti?”. “Benissimo - replica il ragazzo, quasi stupito di quella domanda -. Perché?”. E’ evidente che non ricorda nulla di quanto ha vissuto; risponde franco, senza il sospetto di aver vissuto qualcosa di cui non ha memoria.
Questo genere di esperimenti, Fersen credo li provasse qualche volta per indurre un soggetto ad aprirsi senza forzature psicologiche o scavi nella personalità indotti da comandi razionali, per rendere l’attore più duttile e pronto a recepire, quando si fosse trovato ad affrontare un personaggio, ogni possibile sfumatura di una personalità differente dalla sua.
Da parte di Fersen era, quello con l’individuo singolo, un passo iniziale verso una sorta di liberazione espressiva che andava poi allargandosi e arricchendosi di ulteriori applicazioni, al di là del proprio recinto interiore, attraverso gli altri “gradini” del mnemodramma, che fidando già in una prima fase di “liberazione” si libra a sollecitare la fantasia creativa attraverso l’uso di uno strumento, preso al di là di una sua valenza concreta - bastone, sedia, palla ecc. - come elemento di appoggio al proprio immaginare.
Questo procedimento richiama un po’ quello che anni dopo ha sperimentato Peter Brook usando una sedia e soltanto una sedia sulla scena nuda: trono, cavallo, strumento di contenzione, albero, nave, tutto al di fuori che sedia, e di questo ha scritto indicando la suggestione infinita derivante dalla povertà dell’oggetto, mentre l’oggetto preciso relativo ad una scenografia non fa che imprigionare l’immaginazione a quanto l’occhio vede, con pigrizia, pretendendo altro e altro ancora ad ogni nuovo susseguirsi di azioni. Agendo singolarmente, gli allievi possono poi tutti ritrovarsi in un complesso gruppo articolato che ha come obbiettivo l’oggetto; ognuno vi proietterà il suo immaginario, e si farà disposto a combattere gli altri o ad allearsi con qualcuno contro altri; si instaura una vera e propria battaglia di sopravvivenza, che Fersen non esita a considerare con significati ancestrali e riferimenti antropologici. E’ sempre la sua presenza a tenere sotto controllo l’azione che va via via svolgendosi, e, come lui stesso afferma e come io ho avuto modo di verificare assistendo all’esperimento di cui sopra,
“Gli attori non avvertivano la mia vicinanza (...) Io mi muovevo in mezzo a loro come un fantasma, ero, per la loro realtà, un fantasma: un’ombra inconsistente, a fronte di quelle sostanze essenziali e imponderabili nelle quali si manifestava il loro io profondo”.
Tuttavia la presenza di Fersen si palesa quando se ne prospetti la necessità:
“Nei momenti della violenza o dell’estrema angoscia io mi aggiravo fra i partecipanti, osservandone da vicino le reazioni e controllando l’andamento del mnemodramma: era già accaduto che l’evento straripasse improvvisamente dai suoi argini onirici e irrompesse pericolosamente nella vita reale. L’intervento si rendeva allora necessario”.
L’elemento “angoscia” ricorre nelle osservazioni di Fersen in relazione agli stati d’animo dell’allievo impegnato nel mnemodramma. Lui stesso ne parla in più occasioni attribuendo allo stato in cui viene a trovarsi il soggetto come di una trance, da cui poi si risveglia ad esperimento terminato.
Di quale angoscia si tratti, si può dedurre dal fatto che essa si manifesta in quasi tutti gli attori a cui Fersen abbia suggerito l’esperimento del mnemodramma. E’ un’angoscia che non riguarda una riflessione consapevole di un proprio fallimento, o una situazione relativa ad affetti traditi, condizioni di malattia, frustrazioni di lavoro ecc. E’ invece uno stato che, nel momento in cui il soggetto si abbandona ad una sorta di scorrere interiore, cedendo le resistenze che abitualmente ne condizionano il comportamento, fa emergere dall’inconscio il senso di un’inquietudine che permea la propria esistenza mettendone in evidenza l’incertezza e l’oscurità. Scavando nel proprio io profondo, l’allievo fa afffiorare alla luce questo inesplorato mondo interiore, talvolta foriero di sorprese pericolose e destrutturanti. Ed è per questo motivo che il Maestro deve vigilare e farsi carico della responsabilità di fermare in tempo chi stia andando troppo in là nell’indagine di sé, se questa indagine si profila carica di minaccia all’equilibrio della persona.
Quello di Fersen si può forse rapportare al procedimento maieutico messo in atto da Socrate, che si addentra mediante un’indagine conoscitiva nell’interiorità dell’individuo per metterne alla luce elementi sconosciuti a lui stesso. Esso si incentra quindi soprattutto sul soggetto al centro dell’esperimento ed è finalizzato alla conoscenza di sé.
Aver privilegiato questo tipo di procedimento da parte di Fersen ha forse qualche attinenza con una serie di elementi che tutti conducono alle origini ed alla cultura, oltre che alle esperienze, del Maestro.
Era la sua cultura e la sua stessa esistenza a imprimere l’eco di un dramma ancestrale alle esperienze messe in atto da Fersen quando si è addentrato nella pratica laboratoriale del teatro, dopo un primo periodo di avventuroso approccio ad esso, con magnifici risultati anche drammaturgici. Nato in Polonia, terra perseguitata da invasioni e repressioni, la sua appartenenza ad una famiglia ebrea era stata profondamente segnata dal periodo nazista, attraverso fughe e cambiamenti dei luoghi in cui abitare, frammentazioni familiari, continue paure determinate dalla mancanza di sicurezza. in un periodo in cui vanno facendosi sempre più frequenti le deportazioni naziste, evitate soltanto per una serie di combinazioni e di aiuti di amici fuori dall’Italia, in cui con i genitori era andato a vivere in un periodo di relativa serenità. La sua ricerca di tradizioni delle origini, non solo con suoi scritti ma con scelte drammaturgiche e letterarie, lo portano a privilegiare il dramma inteso come sofferenza ed espiazione, e a ricercarne le fonti di carattere antropologico attraverso cui operare una sorta di ricongiungimento ideale.
Su questo stato fortemente reattivo Fersen si inserisce con una personalità protesa ad indagare sulle origini dell’uomo, in quell’ambito arcaico dei miti e delle radici antropologiche che egli privilegia per differenti motivi, la ricerca delle origini della violenza, il sacro, un senso collettivo all’esistenza in cui l’individuo si trova ad agire. E Fersen si domanda
“se le sconvolgenti esperienze del mnemodramma non attingano alle indistinte matrici del complesso mito-rituale, che racchiude il nucleo primo del teatro”.
Ci si può domandare se il mnemodramma possa avere un legame consequenziale con il teatro che Fersen ha in più direzioni sviluppato, realizzando spettacoli sia da testi originali di sua creazione, sia da commedie da lui tratte dalla Commedia dell’Arte e da testi classici e di repertorio moderno. In forme sfumate egli sosteneva di tenere i due campi divisi, servendosi del mnemodramma per aprire orizzonti nuovi e più vasti ad un teatro futuro, mentre il teatro da realizzare per il pubblico del momento obbediva a regole più vicine alle esigenze di mercato. Ma io ritengo che il lavoro che lui svolgeva nell’ambito del mnemodramma andasse poi a riversarsi, in un modo sotterraneo, in quella spettacolarità accettata come mestiere, attraverso certi interpreti che del mnemodramma avevano sperimentato i criteri, ma soprattutto attraverso l’intuizione che il Maestro aveva acuito nei confronti dei suoi attori, traendo da loro quell’io profondo inesplorato e inconsapevole a loro stessi, che scaturiva attraverso l’incontro e l’intreccio fra l’attore ed il personaggio del testo da rappresentare. La maieutica socratica operava allora arricchendo la personalità dell’attore della fantasmatica figura del personaggio creato dall’autore e filtrato attraverso la sensibilità del regista.
Diverso procedimento applicava Orazio Costa agli allievi lavorando a quello che aveva chiamato “metodo mimico”, per sollecitare la creatività facendola riemergere da personalità spesso appiattite sugli schemi di un’educazione scolare e da comportamenti societari finalizzati all’imitazione. Gli esercizi partivano dal respiro come moto universale comune ad ogni essere umano; da tale respiro si andava poi risalendo all’aria, al vapore, alla nuvola, all’acqua, alla pioggia ed ai fiumi e così via, passando poi a “mimare” ogni elemento, passando poi ai vegetali, agli animali ed ai concetti, per arrivare alla parola ed infine alla parola poetica, nella quale l’allievo si immedesimava entrando nel percorso creativo già realizzato dal poeta, e inserendovi la propria sensibilità.
Tale procedimento può richiamare la visione delle ombre della caverna descritte da Platone: un recepire ciò che è fuori facendolo proprio e arricchendosene mediante un lavoro mimetico nel quale diventare tutto ciò che si va a vedere, ad osservare, a sentire. Si tratta di un processo di immedesimazione, non di imitazione, un’uscita da sé ed un ritorno a sé, arricchito da quella uscita precedente: un procedimento, cioè, che fa emergere la capacità espressiva dall’interno dell’allievo verso quell’esterno popolato di elementi, di esseri animati, di simboli, di creazioni poetiche. E’ un metodo che consente di diventare ogni cosa senza traumi personali, in quanto ogni cosa viene inglobata nella personalità di chi la interpreta rimanendo se stesso, ma ampliandosi rispetto a ciò che va ad interpretare, non restando cioè limitato alla propria dimensione ed alla propria esperienza - come avviene nel primo Stanislawskij -, ma dilatandosi quanto occorre per poter interpretare personaggi che non potrebbero essere contenuti nel proprio limitato vissuto.
Anche in Fersen, in un certo senso, il mito della caverna si riattualizza nel lavoro che viene realizzato andando a cercare quelle imagini - o protoimmagini - che fanno parte dell’archeologia del soggetto. La personalità limitata del soggetto va quindi ampliandosi mediante il recupero delle radici.
Ciò che avvicina Fersen a Costa è prima di tutto l’idea di uomo e poi di attore.
Prima di fare un attore - dice Costa - bisogna fare un uomo. Egli intende uomo nella sua accezione più completa circa la sua espressività e la sua dignità di essere umano: che sa esprimersi al meglio ed al massimo è anche uomo completo sul piano morale, nei rapporti con gli altri, nella sua capacità di osservare e di comunicare. Per arrivare a questo livello espressivo occorre cancellare dalla propria persona ogni forma di stratificazione derivata dalle costrizioni indotte dalla società: le infinite falsità del comportamento per mascherare il proprio sentire, il più delle volte a proprio vantaggio, celando agli altri i propri disegni di azione. E’ in sostanza un ritorno alla purezza iniziale dell’essere umano, facendo cadere le maschere che inducono a truccare se stessi.
Se Fersen era partito, per i suoi esercizi, dal metodo Stanislawsky, e forse lo aveva in qualche modo applicato, non vi si era fermato a lungo. Non gli piaceva quell’eccesso di naturalismo che riteneva potesse avere senso per un Cecov inteso soltanto in tale dimensione, ma non quando si superasse il clima di una quotidianità vissuta realisticamente. Voleva andare più in profondità. Con il mnemodramma ci andò, ma i risultati di tale sperimentazione rimasero quasi del tutto come un lavoro di approfondimento dell’impegno dell’attore; il salto dal mnemodramma al testo, a quanto io ne abbia ricercato prove, non avvenne. Ci furono due spettacoli che dal mnemodramma attinsero risultati accantonati in mesi di lavoro con un gruppo di attori. Si trattò di “Diavolerie” rappresentato a Spoleto nel 1967 e di “Leviathan” ancora a Spoleto nel 1974. Ma lo stesso Fersen dichiarò che si trattava soprattutto di esercizi derivanti da lunghi e ripetuti momenti di laboratorio. In essi apparivano azioni legate all’uso di materiali che via via si trasformavano - come i bastoni del primo, che diventavano fra le agili mani degli attori oggetti via via sempre diversi - oppure si manifestavano attraverso momenti collettivi di forte intensità emotiva che offrivano agli spettatori immagini sorprendenti. Ma l’utilizzazione del mnemodramma per arrivare a interpretare un testo non avvenne. Era lo stesso mnemodramma, io credo, a costituirsi come elemento purificatore; l’interpretazione del testo era poi cosa che veniva realizzata secondo criteri e suggerimenti relativamente tradizionali. L’innovazione consisteva nella purificazione interiore dell’attor, avvenuta in precedenza e vissuta come liberazione implicita.
Va anche osservato che pur non consapevolmente, ma attraverso scelte apparentemente casuali - ad esempio la “Lea Lebowitz” con le scene e i costumi di Luzzatti, inventata per colpire, loro ancora sconosciuti, il mondo del teatro -, Fersen andava recuperando una tradizione ebraica, che vedrà nascere successivamente “Golem” e “Leviathan”. A sua volta Costa, fin dalla sua formazione operata attraverso Silvio D’Amico e poi Jacques Copeau, tendeva ad un recupero di origini cristiane, sia attraverso rappresentazioni riprese in anni successivi, delle “Laudes”, sia poi del “Poverello” di Copeau e di “Assassinio nella Cattedrale” di Eliot, fino ai drammi di Ugo Betti e di Diego Fabbri, ma anche in un sentire sempre attento alla spiritualità dell’uomo.
In questa loro tensione i due maestri cercano di recuperare al teatro una collettività smembrata, come quando il teatro greco si faceva interprete della polis.
L’incontro fra l’attore ed il personaggio è sempre un impatto di forte pregnanza emotiva. Entrare nell’”altro” è frutto di esercizio e di disponibilità. Che si tratti di mnemodramma o di mimesica, forse non è essenziale. Ci sono persone naturalmente mimiche - com’era la Duse, com’era Ruggeri - che ignoravano Fersen e Costa.
Ricordo un bellissimo seminario ad Avignon, tenuto da Jean Vilar, in cui il grande creatore di quel Festival e soprattutto del TNP aveva invitato alcuni fra i giovani registi ed attori di quegli anni per dialogare con loro. Io ero fra questi, ed ero stata da lui chiamata “la Costienne”. Voleva sapere, il Maître, quali “trucs” potevamo suggerirgli, arrivando da scuole ed esperienze diverse, perché intendeva fare un’Ecole tutta nuova, forse riecheggiando Copeau, ma con la voglia di qualcosa di nuovo. E tutti noi, venuti da varie nazioni e continenti, a raccontargli di quello che facevamo. Ascoltava curioso, attento come un fervido studente, prendeva appunti, faceva domande, chiedeva di dimostrare quanto si diceva. Alla fine si rese conto che era impossibile individuare una possibilità unica per apprendere come interpretare. Ogni truc era buono, dipendeva dalla fede di ognuno al proprio lavoro, dalla passione, ed anche da una certa buona fede, intelligenza e dovizia di mezzi, ma soprattutto dalla pazienza, dalla tenacia, dalla caparbia volontà di essere, di diventare.
Alla luce del mnemodramma, che tanta parte del libro tiene non solo per quantità di pagine quanto per l’importanza dell’argomento che si trascina anche il discorso relativo all’antropologia ed alla matrice mitico-rituale che ne è conseguenza, sui quali si sofferma opportunamente Luigi M. Lombardi Satriani nelle pagine che precedono, mi pongo una riflessione sul titolo dello scritto di Fersen, “Il teatro, dopo”. Ho cercato di capire, fin dalla prima lettura, perché quel “dopo”, che invita ad una previsione circa un teatro diverso da quello del tempo in cui Fersen fissò le sue riflessioni. “Dopo”, certo. Ma, forse, “oltre”. Oltre il teatro consumistico, mercificato, per cui
“all’adempiersi di un evento collettivo si è sostituito il mito commerciale del ‘successo’: all’instaurarsi di una totalità profonda , il totale dei biglietti venduti”.
C’è amarezza in queste riflessioni, ma anche una sorta di rivalsa nel volersi imporre come fautore di una nuova era del teatro, mediante il ritorno ad una purezza di interpretazione che, pur creandosi al di fuori dei circuiti ufficiali dello spettacolo, prende vita e comincia a circolare attraverso i giovani interpreti, a “infettare” come una peste artaudiana la perfezione formale di un teatro di consumo, e ad insinuare nel pubblico il desiderio di una nuova forma di condivisione, dimensione perduta e necessaria perché il teatro abbia ancora la sua funzione insostituibile.
Ne “Il teatro, dopo”, Laterza ed., Bari, 1980, Il mnemodramma visionario, p. 110.
Ibidem, pp.109-110.
Ibidem, La patria mitica, p. 117.
Ibidem, L’agonia dello spettatore, p.21.
